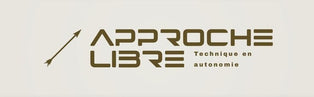La cucina medievale è tanto affascinante quanto sconcertante. Tra banchetti traboccanti di spezie e semplici pasti contadini, spesso ci perdiamo in immagini idealizzate. Eppure, grazie a manoscritti culinari, registri contabili, scavi archeologici e trattati d'epoca, oggi possiamo ricostruire in modo affidabile i cibi consumati nel Medioevo, tra il XIII e il XV secolo.
Ecco un riassunto delle pratiche alimentari medievali, con particolare attenzione alla Francia e alle regioni limitrofe.
Una cucina basata sui cereali
Come nell'antichità, la base della dieta medievale rimaneva il pane e i cereali. Il grano era riservato ai più ricchi e alle città, mentre nelle campagne si consumavano principalmente segale, orzo, avena o grano saraceno, a seconda della regione.
I cereali vengono consumati sotto forma di pane (integrale, scuro, bianco o misto), porridge, frittelle spesse, flan o farina per addensare le salse. Il pane bianco rimane un lusso riservato a nobili ed ecclesiastici.
Legumi e verdure dell'orto
Piselli, fave, lenticchie, ceci e alcuni tipi di fagioli (in particolare i fagioli rampicanti, importati dalla Spagna) erano comuni. Venivano utilizzati in zuppe, purè o stufati.
Gli orti medievali fornivano verdure semplici ma nutrienti tutto l'anno: cavoli, rape, porri, carote tradizionali, pastinache, cipolle, aglio. Si consumavano anche foglie di barbabietola, crescione, ortiche e altre verdure.
Carne: abbondante o scarsa a seconda dello stato
I nobili consumavano molta carne, spesso come parte di banchetti o pasti codificati: selvaggina (cervo, cinghiale, lepre, coniglio), pollame nobile (cigno, pavone, airone) e carni d'allevamento come manzo, montone, agnello e soprattutto maiale.
La gente si arrangiava con carne di maiale, pollame o frattaglie. La carne veniva spesso salata, affumicata o cotta a fuoco lento in un calderone. I giorni di digiuno imposti dalla Chiesa proibivano la carne per diversi giorni alla settimana; in questi giorni si consumavano pesce, uova o latticini.
Salumi e tecniche di conservazione
I salumi sono molto comuni sia nella cucina rurale che in quella urbana. Pancetta affumicata, sanguinaccio, salsicce, andouille, paté e carni conservate nel loro grasso sono tutti facilmente reperibili. La salatura, l'essiccazione e l'affumicatura consentono di conservare la carne per diversi mesi. Questi prodotti vengono utilizzati anche per arricchire zuppe e stufati.
Latticini: presenti ma variabili
Il latte viene raramente bevuto così com'è, ma viene trasformato in cagliata, formaggio fresco o stagionato. Il burro è consumato principalmente nelle regioni settentrionali, la panna in alcune ricette raffinate e il siero di latte nelle zuppe.
I latticini svolgono un ruolo importante nelle diete magre prescritte dalla Chiesa.
Frutta e dolci naturali
Mele, pere, prugne, ciliegie, more, noci, castagne e nocciole sono frutti comuni. Questi frutti possono essere consumati crudi, essiccati o aggiunti a piatti dolci e salati.
Lo zucchero di canna era un bene di lusso importato, riservato all'aristocrazia. Il miele era più comune e veniva utilizzato per dolcificare, conservare o aromatizzare. Le marmellate erano spesso originariamente medicinali (elettuari) o preparate in sciroppi densi.
Spezie: gusto e prestigio
La cucina della nobiltà medievale è rinomata per l'uso generoso di spezie: pepe, zenzero, cannella, chiodi di garofano, grani del paradiso, noce moscata... Sono costose e simboleggiano ricchezza e raffinatezza.
Queste spezie vengono utilizzate in salse, stufati e persino porridge. Il sapore desiderato è spesso agrodolce, ottenuto con l'uso di agresto, aceto, succhi di frutta acidi o erbe aromatiche come prezzemolo, salvia, maggiorana o issopo.
Cucinare nel calderone: il cuore della casa
In tutti gli strati sociali, il calderone è l'utensile centrale. Sospeso nel focolare, appoggiato su un treppiede o direttamente sulla brace, permette di cucinare quasi tutti i piatti quotidiani.
Preparano quanto segue:
— zuppe dense, brodi, stufati
— stufati di carne, verdure e legumi
— salse dense fatte con pane e spezie
— piatti cotti a fuoco lento per diverse ore
La cottura avviene su un letto di brace, senza fiamma diretta, a circa 95°C. È una cucina di pazienza, di lentezza, ma anche di grande efficienza: pochi utensili, tanto sapore e cottura uniforme.
Il calderone è associato al calore, alla sopravvivenza e alla condivisione.
Pane e zuppa: i pilastri di una dieta sana
Alcune ricette contadine prevedevano la cottura del pane direttamente nel calderone, sopra le braci, adagiando l'impasto su un letto di paglia o foglie. Il pane, così diffuso in molti piatti, veniva spesso intinto in zuppe o stufati. Per le famiglie più povere, un pasto a volte consisteva solo in una fetta di pane scuro intinta nella zuppa.
Zuppa, termine generico, si riferisce a qualsiasi liquido caldo contenente pane, verdure, cereali o avanzi. È il piatto più comune, condiviso quotidianamente attorno alla pentola.
Bevande: vino, birra, sidro, idromele
Il vino è ampiamente consumato, anche diluito con acqua o bollito. La gente comune beve principalmente birra chiara, birra non luppolata, sidro o idromele. Sono disponibili anche infusi di erbe e talvolta brodi fermentati.
L'acqua raramente viene bevuta da sola, spesso viene mescolata con altri ingredienti per evitare contaminazioni.
Una cucina codificata, rustica e sofisticata
La cucina medievale era scandita dalle stagioni, dai divieti religiosi e dallo status sociale, ma anche da una grande capacità di adattamento. I ricettari nobiliari rivelano una cucina inventiva, raffinata e saporita. Ma la cucina popolare, più semplice e sobria, dimostra grande creatività nell'utilizzo degli avanzi.
La cottura nel calderone è uno dei capisaldi di questa cultura culinaria: semplice, ma generosa.
Ora puoi ordinare i tuoi kit di ricette medievali per cucinare nel calderone.
Tutto il materiale necessario per iniziare è disponibile sul sito web!

Per saperne di più:
– Il Viandier di Taillevent (XIV secolo), a cura di T. Scully
– La famiglia di Parigi (1393), a cura di Brereton & Ferrier
– Odile Redon et al., Cuisine au Moyen Âge, ed. Azione
– Bruno Lemesle, “Fuoco e cucina domestica nel Medioevo”, in Archeologia Medievale, 2002
– Jacques Thirion, Il calderone e l'alambicco, CNRS