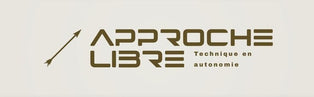E se mangiassimo come i Galli?
Prima della romanizzazione, i popoli celtici vivevano secondo una cucina locale, semplice ma ricca di sapori. Grazie alle recenti ricerche archeologiche, oggi possiamo ricostruire con precisione la loro dieta quotidiana. Dimentichiamo le caricature e immergiamoci in un mondo culinario antico di oltre duemila anni.
Ecco una panoramica degli ingredienti presenti in Gallia durante il periodo celtico (prima del 1520) e utilizzati nella loro dieta quotidiana.
Cereali: la base della dieta
I Galli erano eccellenti agricoltori e i cereali costituivano la base della loro dieta. Li consumavano sotto forma di densi porridge, focacce, pani rustici, incorporati in stufati o trasformati in bevande fermentate.
Tra i cereali attestati dall'archeologia troviamo l'orzo coperto (Hordeum vulgare, molto comune), il miglio (Panicum miliaceum, resistente e comune), nonché i frumenti coperti: il farro (Triticum spelta), il farro dicocco (Triticum dicoccum) e, più marginalmente, il monococco (Triticum monococcum).
Sono attestate anche la segale (Secale cereale) e l'avena (Avena sativa), ma sembrano aver svolto un ruolo secondario: la prima era probabilmente ancora considerata un'erba infestante, mentre la seconda veniva utilizzata principalmente come foraggio per i cavalli, anche se potrebbe essere stata consumata occasionalmente anche dagli esseri umani.
Tuttavia, il grano tenero (Triticum aestivum), che costituisce la base della nostra dieta odierna, non era ancora coltivato in Gallia prima della romanizzazione. Allo stesso modo, non esiste traccia di mais o riso in Gallia durante questo periodo.
Legumi
I legumi svolgevano un ruolo essenziale nell'equilibrio dei pasti: fornivano proteine di origine vegetale e potevano essere conservati bene durante tutto l'anno.
Gli alimenti più comuni rinvenuti erano fave, piselli spezzati e, in misura minore, lenticchie. Gli archeologi talvolta identificano anche cicerchie, vecce o lupini. Alcuni semi, come il lino o il papavero, venivano utilizzati, in particolare per la produzione di olio o come guarnizione.
Niente ceci o fagioli secchi: questi sarebbero arrivati molto più tardi, con il commercio mediterraneo o transatlantico.
Verdure a radice e verdure a foglia verde
La Gallia offriva una splendida varietà di verdure resistenti, adatte al clima temperato e ai metodi agricoli dell'epoca.
I Galli coltivavano o raccoglievano rape, carote antiche, pastinache, cavoli ricci, cipolle, aglio e porri selvatici. Utilizzavano anche verdure a foglia verde come ortiche, cime di rapa, foglie di cavolo ed erbe selvatiche raccolte localmente.
Naturalmente non c'erano patate, pomodori o melanzane, tutti prodotti provenienti dall'America molto tempo dopo l'antichità.
Carne, pesce, uova
La carne non veniva consumata tutti i giorni, ma era parte integrante della dieta, soprattutto durante i pasti comuni o le feste.
I suini costituivano la principale fonte di carne, grazie a un allevamento ben controllato e adattato alle esigenze collettive. Altre specie domestiche integravano questa offerta: bovini, ovini, caprini, nonché pollame (polli, oche, anatre, piccioni), allevati su piccola scala o in regime semi-brado.
La selvaggina – cinghiale, lepre, capriolo o cervo – veniva cacciata in modo opportunistico, a seconda della stagione, delle risorse locali e probabilmente dello status sociale. Il coniglio selvatico, endemico della Gallia meridionale, poteva essere cacciato e mangiato occasionalmente, ma solo nella Gallia mediterranea, dove il suo habitat naturale lo rendeva facilmente reperibile.
Le uova, sebbene raramente conservate nei reperti archeologici a causa della loro fragilità, molto probabilmente venivano consumate, in particolare le uova di pollame.
Per quanto riguarda i pesci, la loro scarsa presenza nei siti di scavo è in gran parte spiegata dalla scarsa conservazione delle loro ossa. Tuttavia, diversi studi isotopici su ossa umane suggeriscono un consumo occasionale di risorse acquatiche, in particolare in aree fluviali o costiere come la valle della Saona, la costa atlantica o quella mediterranea.
La gastronomia
La lavorazione della carne, in particolare di quella suina, era una pratica consolidata. Nei resti sono state rinvenute chiare tracce di salumi:
— pancetta salata o affumicata
— grassi fusi conservati in barattoli
— probabilmente forme di rillettes rustiche o carne confit nel suo stesso grasso
— e, in alcune regioni, forse sanguinacci o preparazioni fatte con sangue e frattaglie
Queste tecniche consentivano di conservare la carne anche al di fuori della stagione della caccia o della macellazione e contribuivano all'equilibrio del sapore dei piatti aggiungendo grassi e sale naturale.
Prodotti lattiero-caseari
Contrariamente a quanto si crede, i Galli utilizzavano i latticini, soprattutto nelle zone dedite all'allevamento del bestiame.
Probabilmente stavano consumando:
— latte di capra, pecora o mucca, raramente crudo
— formaggi freschi o cagliati, consumati rapidamente
— latti fermentati,
— e in alcuni casi, burro, in particolare nella Gallia settentrionale
Questi prodotti erano deperibili e quindi mal conservati dal punto di vista archeologico, ma il loro utilizzo è indirettamente confermato dalle tracce di grassi animali sulla ceramica.
Frutta, noci e bacche
La frutta, sia selvatica, semi-coltivata o proveniente da frutteti rustici, occupava un posto importante nella dieta dei Galli: consumata cruda, cotta, essiccata o fermentata, forniva varietà, sapore ed energia.
Tra i più comuni ci sono:
Mele rustiche, pere selvatiche, prugne, spesso raccolte da varietà locali, più acide della nostra frutta moderna.
Nocciole, ghiande dolci, faggiole e castagne a seconda della regione, ricche di lipidi e carboidrati.
Uva selvatica (vitigni non coltivati), probabilmente utilizzata per semplici preparazioni fermentate o essiccata.
E soprattutto, i frutti di bosco. Gli scavi archeobotanici e le fonti etnobotaniche ci permettono di elencarne diversi:
Prugnole (Prunus spinosa): molto astringenti se crude, venivano probabilmente cotte o essiccate per accompagnare piatti rustici o come legante.
Bacche di sorbo (Sorbus aucuparia e domestica): utilizzate dopo essere state ammorbidite o essiccate, a volte come condimento aspro o per preparare bevande fermentate.
Bacche di sambuco nero (Sambucus nigra): cotte o essiccate, possono essere aggiunte ai porridge o fermentate.
More (Rubus fruticosus): raccolte di stagione, consumate fresche, essiccate o trasformate.
Cinorrodi (frutti della rosa selvatica): ricchi di vitamina C, probabilmente utilizzati sotto forma di pasta o decotto.
Bacche di ginepro (Juniperus communis): molto apprezzate per aromatizzare stufati, carni e birra, e persino per conservare gli alimenti. Il loro utilizzo è ampiamente documentato.
Cornioli (Cornus mas): frutti agrodolci che si consumano maturi, talvolta cotti o fermentati.
Lamponi, ribes e mirtilli: si trovano principalmente nelle zone boschive o montuose e si consumano freschi o secchi.
Azerole (Crataegus azarolus) e altri piccoli frutti da siepe, talvolta utilizzati per addensare o addolcire un piatto.
Alcune di queste bacche avevano una funzione medicinale, altre aromatica, ma la maggior parte erano principalmente risorse stagionali utilizzate tal quali o incorporate in piatti semplici (porridge, pani alla frutta, salse grezze).
Erbe e spezie
Contrariamente all'immagine a volte austera che abbiamo della loro cucina, i Galli sapevano benissimo come arricchire i loro piatti con erbe aromatiche locali, provenienti dalla raccolta spontanea o dalla coltivazione domestica.
Grazie agli scavi archeologici, alle analisi dei semi carbonizzati e alla conoscenza della flora dell'epoca, oggi possiamo tracciare una panoramica realistica e articolata dei sapori utilizzati nella cucina gallica.
In tutta la Gallia si riscontra il seguente utilizzo:
-
finocchio selvatico , apprezzato sia per i suoi semi che per i suoi steli profumati,
-
Timo selvatico ( serpolet ), abbondante nei prati,
-
Menta selvatica , per aromatizzare bevande o porridge.
-
aglio selvatico , molto comune nel sottobosco,
-
Le ortiche , ricche di minerali, vengono utilizzate come verdura o erba aromatica.
-
coriandolo selvatico , a volte trovato sotto forma di semi nei siti scavati,
-
così come semi di papavero o di lino , utilizzati come condimento o fonte di olio.
Nella Gallia mediterranea, le popolazioni insediate a sud della Loira, e ancor più vicino ai Pirenei, alla Provenza o alla Linguadoca, vivevano nel cuore di una flora aromatica eccezionale, ancora oggi visibile nella macchia mediterranea e nella gariga.
Lui è Pertanto è altamente probabile, anche se difficile da provare archeologicamente, che utilizzassero anche:
-
rosmarino ( Rosmarinus officinalis ),
-
l' alloro nobile ( Laurus nobilis ),
-
salvia comune ( Salvia officinalis ),
-
saporito ,
-
issopo ,
-
dragoncello selvatico .
Queste piante sono originarie della regione e il loro utilizzo era ovviamente noto alle società di cacciatori-raccoglitori per scopi alimentari, medicinali e per aromatizzare le loro preparazioni.
I piatti cotti a fuoco lento nei calderoni, come zuppe di cereali, stufati di carne o densi porridge, venivano arricchiti da queste erbe profumate, che svolgevano il ruolo di aromi ben prima dell'introduzione delle spezie orientali.
Il sale veniva utilizzato in piccole quantità, spesso compensate dalla salatura, dall'uso di aceto delicato o di birra come esaltatore di sapore.
Riscoprite il gusto della cucina gallica!
Il Respiro di Cernunno è una miscela di erbe aromatiche ispirata alle tradizioni celtiche, che riflette le pratiche alimentari documentate in varie parti della Gallia prima della romanizzazione. È quindi ideale per la cottura in calderoni e per piatti a fuoco lento .
Voglio scoprire gli Aromatici della Gallia adesso
Bevande
La Cervoise, una birra rustica e non luppolata, prodotta con l'orzo, era la bevanda emblematica dei Galli. Veniva spesso consumata calda, a volte addolcita con un po' di miele o frutta. Esisteva anche l'idromele. Acqua, infusi di erbe e decotti facevano anch'essi parte della loro vita quotidiana.
Prima dell'influenza romana, il vino non era ancora ampiamente distribuito nella Gallia interna. Tuttavia, importazioni di vino etrusco e greco sono attestate a partire dal V secolo a.C. in contesti d'élite (come a Vix o Lattara), in particolare sotto forma di anfore e crateri per libagioni.
Un pasto cucinato nel calderone
I Galli cucinavano molto spesso in calderoni o pentole di terracotta su fuochi a legna. Preparavano porridge di cereali, stufati di carne, verdure e legumi, o piatti di purè densi e nutrienti.
Il pane poteva anche essere cotto in un calderone, su un letto di foglie o paglia, o sotto forma di una focaccia densa e schiacciata. A differenza della cottura del pane, che richiede un fuoco alto e un calderone molto caldo, i piatti di tutti i giorni venivano cotti lentamente sulla brace a circa 95 gradi Celsius.
Cucina semplice, rustica e gustosa
Lungi dall'essere frutto di fantasie o folklore, la dieta gallica era equilibrata e sorprendentemente ricca.
Ritornare oggi a questa cucina significa riscoprire tecniche antiche, una giusta sobrietà e un gusto profondamente radicato nella vita.
I kit per la ricetta del calderone Gauloises sono ora disponibili sul sito web!
Troverete anche tutta l'attrezzatura necessaria per iniziare subito.
Dove posso trovare cereali e legumi antichi?
Per riscoprire i sapori autentici della cucina gallica è fondamentale utilizzare cereali e legumi di varietà antiche , coltivati con metodi di agricoltura biologica.
Diversi settori offrono oggi questi prodotti, tra cui mulini, cooperative biologiche e piccoli produttori specializzati.
Tra questi, Moulin des Moines , in Alsazia, occupa un posto importante nella promozione dei cereali biologici .
Azienda familiare pioniera nell'agricoltura biologica fin dagli anni '70 , lavora anche i cereali con metodi tradizionali, in particolare tramite la macinazione a pietra.
Per acquistare facilmente i tuoi cereali e legumi biologici, puoi visitare il loro sito web: Mulino dei monaci

Per saperne di più:
– Jean-Louis Brunaux, I Galli (Les Belles Lettres, 2018)
– Christian Goudineau, Regards sur la Gaule (Seuil, 2001)
– Venceslas Kruta, I Celti: storia e dizionario (Robert Laffont, collezione Bouquins, 2000)
– Jean-Paul Savignac, Cibo e cucina dei Galli (Errance, 2004)
– Brigitte Lion e Jean-Marie Durand (a cura di), Pratiche alimentari nelle società antiche (La Découverte, 2014)